
Watch
Estirpare le radici del razzismo dentro di me
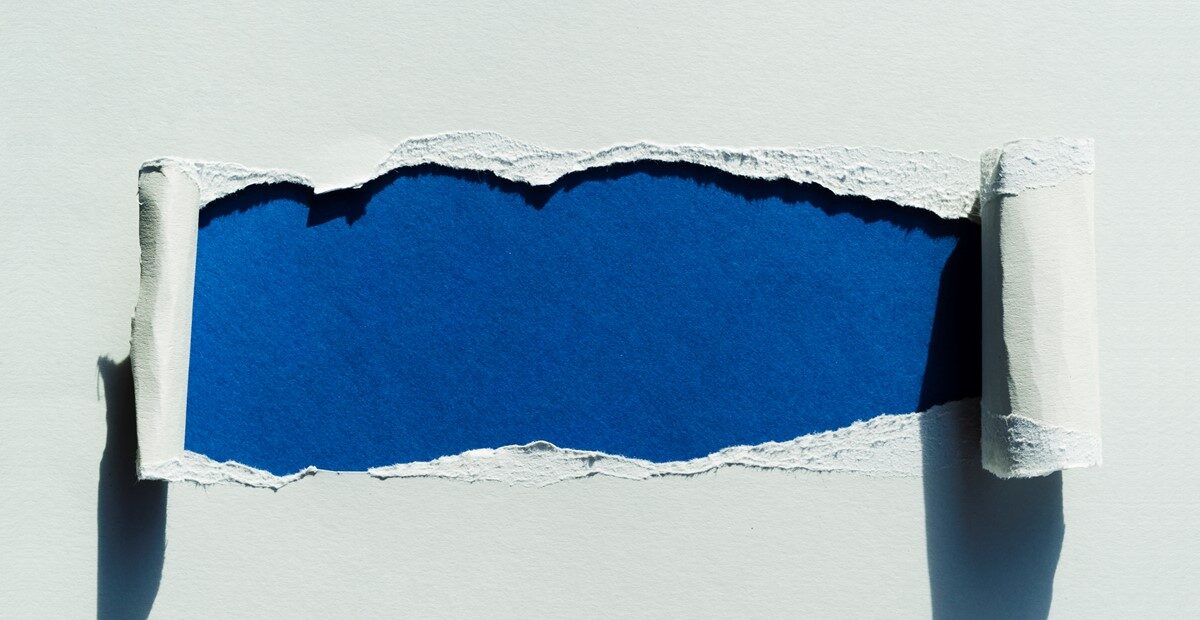
Vi proponiamo la storia scritta in prima persona da Nancy O’Donnell, psicologa statunitense che vive a Loppiano (Fi), cittadella internazionale dei Focolari in Italia. Stimolata dall’ondata di proteste che ha fatto seguito alla morte di George Floyd, il 25 maggio scorso, Nancy, nel suo racconto ricorda gli anni della battaglia per i diritti civili nel suo paese, il suo desiderio di giustizia e l’impegno per estirpare le radici del razzismo.
È stata un’esperienza emozionante quella di scrivere questa storia dopo tanti anni. A volte, guardando indietro, mi chiedo come sarebbe stata diversa la realtà se avessimo permesso a figure come Martin Luther King e Bob Kennedy di raggiungere i propri sogni. E insieme a quei nomi riaffiora nella mente un’immagine, sembra la scena di un film, ma non lo è.
Marzo 1965. Una ragazza di diciotto anni appena compiuti, secondo semestre del college, sdraiata sul letto del dormitorio, sta studiando per un test. Una cara amica apre la porta della sua stanza ed esclama: “Andiamo in Alabama! Parteciperemo ad una marcia. Vieni con noi! Devi solo chiedere il permesso ai tuoi genitori!” Quasi senza pensare, lei salta giù dal letto, corre lungo il corridoio fino al telefono e chiama a casa (niente telefoni cellulari nel 1965). “Grazie a Dio qualcuno, nella nostra famiglia, ha deciso di fare qualcosa” è l’unico commento di suo padre.
Quella ragazza del college non sapeva quanto le avrebbero cambiato la vita quelle parole di suo padre.
Quella ragazza del college ero io.

Insieme ad altre giovani della nostra piccola università cattolica femminile di Pittsburgh, e ad un gruppo di studenti delle università vicine, salimmo a bordo di un autobus diretto a Montgomery, in Alabama. Potevamo portare con noi solo un piccolo zaino con pochi oggetti personali, ma non ci importava! Credevamo tutte nella stessa causa ed avevamo una carica enorme di energia.
Per i più appassionati di storia, descrivo un po’ il contesto in cui ci trovavamo. Siamo nel bel mezzo del movimento per i diritti civili degli anni ‘60. Una marcia di protesta, organizzata da Selma a Montgomery, era stata brutalmente fermata dalla polizia. Quella giornata prese il nome di “Bloody Sunday” (domenica di sangue). Tra i contestatori c’era un pastore di Boston, il reverendo James Reeb, ministro della Chiesa Unitaria Universalista, padre di quattro figli e attivo nel Movimento per i diritti civili. Due giorni dopo quella marcia il reverendo Reeb fu assassinato a sangue freddo per le strade di Selma. Fu questa la “goccia” che fece traboccare il vaso e spinse quel gruppo di studenti universitari, ingenui ed entusiasti, a percorrere circa 1500 km con l’unico scopo di marciare per ottenere giustizia per il reverendo Reeb.
Ritorno al pullman per l’Alabama. Durante il viaggio abbiamo cantato canzoni di protesta, parlato, dormito e riflettuto su ciò che ci aspettava. Ad un certo punto, deve essere stato un po’ dopo l’alba, un giovane si alzò e andò al microfono. Indossava la tipica felpa di SNCC (Student Non-Violent Coordinating Committee) di cui anch’io ero membro. Iniziò ad istruirci su come proteggerci in una serie di possibili scenari: polizia a cavallo, squadre di polizia con i bastoni, gas lacrimogeni, ecc. Ricordo che il terrore e il senso di incertezza crescevano dentro di me mentre lui parlava, ma mi guardai bene dal far trasparire sul volto questi sentimenti: immediatamente mi sforzai di mostrare un’espressione coraggiosa come quella che avevano tutti gli altri intorno a me. Un consiglio in particolare mi rimase impresso: non separarti dalla folla, se ti isolano verrai sicuramente sconfitta. Questa è la loro tattica.
Arrivammo a Montgomery verso sera. Facemmo un sit-in durante il quale qualcuno mi consigliò di indossare la mia felpa al rovescio. Il problema era che c’era scritto il nome della mia scuola “Mt. Mercy College”. “L’unica cosa peggiore di essere una ragazza bianca del nord che viene qui a marciare per i negri, è essere cattolica.”. Un’altra lezione di vita mi era arrivata dritta in faccia.
A marzo, in Alabama, fa caldo e il giorno dopo splendeva il sole. Non ho idea di quanti fossimo, ma non eravamo certo migliaia. Ricordo di aver cantato tanto, a braccetto con quelli che erano accanto a me, mentre guardavo le persone che ci osservavano senza parole e mi chiedevo cosa stessero pensando.
Forse ero troppo presa dalle mie riflessioni, ma a un certo punto mi resi conto di essere molto vicina agli ultimi manifestanti e non ero più a braccetto con gli altri. Davanti al Campidoglio di Stato la marcia si fermò e così pure il canto. Per alcuni istanti ci fu silenzio. Mi voltai e vidi una fila di poliziotti a cavallo pronti con le loro mazze. C’erano schieramenti simili su entrambi i lati della strada. All’improvviso, tutti si mossero verso di noi. Scoppiò il panico, tutti urlavamo. Iniziai a correre, persi una scarpa e mi trovai sola, completamente separata dal gruppo. Un ufficiale di polizia era proprio dietro di me e faceva minacciosamente oscillare il suo manganello. Mi accovacciai, cercando di proteggermi la testa, in attesa che sferrasse il colpo. Ma in quell’istante qualcuno mi afferrò e mi riportò in mezzo alla folla che si stava ritirando. Feci in tempo a sentire il colpo destinato alla mia testa, passare come il vento fra i capelli. Una volta “al sicuro”, circondata dagli altri manifestanti, mi guardai indietro. Quell’agente di polizia mi stava seguendo, a breve distanza. Quando i nostri sguardi si incrociarono, nei suoi occhi vidi solo odio. Ebbi l’impressione che non mi vedesse come una persona, ma piuttosto come ciò che rappresentavo: la fine del mondo così come lui lo conosceva, una sfida a ciò che aveva imparato e interiorizzato fin dalla sua infanzia. Ho continuato a camminare, sentendo il respiro del cavallo sul mio collo. Quello sguardo rimase impresso a fuoco nella mia anima.
Nell’Alabama degli anni ’60, in piena segregazione raziale, raggiungemmo la “sicurezza” solo entrando nel quartiere nero della città, dove ci accolsero calorosamente con abbracci ed applausi.
Verso sera, ricevemmo la notizia che era in arrivo il reverendo Martin Luther King e ci sistemammo tutti lungo la strada dove sarebbe passata la sua auto. Questa volta ero in prima fila. Mentre la sua macchina si fermava brevemente proprio di fronte a me, lo raggiunsi attraverso il finestrino aperto e gli strinsi la mano. Mi guardò e disse: “Grazie per essere venuta”. Non dimenticherò mai i suoi occhi. Trasmettevano amore e bontà, esattamente l’opposto di quello che avevo sperimentato prima. Quello sguardo prese posto, nella mia memoria, accanto a quello precedente e, nelle settimane e mesi seguenti, queste due immagini rappresentarono la domanda fondamentale della mia vita in quel momento: chi avrebbe vinto? L’amore o l’odio? La bontà o il male?
Tornai alla mia vita universitaria, ma qualcosa in me era cambiato per sempre. Quando King e poi Bob Kennedy furono assassinati nel 1968, le speranze della mia generazione per un cambiamento caddero a pezzi. Mi ero appena laureata e stavo andando alla scuola di specializzazione a New York, praticamente convinta che il male avesse vinto. Un senso di disperazione mi riempì e mi convinsi del fatto che avremmo dovuto semplicemente far saltare in aria il mondo intero e ricominciare daccapo.
Ciò che mi ha salvato da queste disastrose riflessioni è stato un incontro avvenuto l’anno dopo la mia esperienza in Alabama. C’erano persone, seguaci di Chiara Lubich, profondamente convinte, ed effettivamente convincenti, che Dio, che è Amore, è la forza più potente del mondo. Ero molto attratta dalle loro idee e dal loro stile di vita. Mi ci vollero alcuni anni, ma nel 1969, decisi di agganciare il mio vagone alla stella di Chiara e seguire quel suo metodo, l’amore, che credevo sufficientemente potente per portare un cambiamento positivo, sia in un mondo spezzato che in me.
Sono partita per un’esperienza di due anni a Loppiano, una delle cittadelle internazionali del Movimento dei Focolari. Qui ho incontrato giovani di tutto il mondo. Quando sono arrivate quattro giovani donne dal Camerun, mi presi cura di loro. Avevo imparato alcune parole in italiano e quindi potevo dar loro una mano con le traduzioni. Una sera abbiamo avuto il compito di lavare i piatti con una lavastoviglie industriale. Mentre spiegavo loro come usare questa macchina, ho scoperto dentro di me un atteggiamento che non potevo credere fosse mio: mi sentivo come un colonizzatore, che insegnava qualcosa a un popolo inferiore. Mi sono sentita male, proprio fisicamente e sono dovuta andare via per cercare di elaborare ciò che credevo Dio stesse cercando di dirmi. Avevo bisogno di scavare più a fondo se volevo estirpare le radici del razzismo in me.
Un altro momento cruciale è stato anni dopo, quando lavoravo come psicologa in una clinica nello stato di New York. Un collega afroamericano e io abbiamo avuto una conversazione sull’uso della parola “nero”. Mi sono resa conto che quasi ogni uso del colore nero indicava qualcosa di negativo o pericoloso. Mi sono anche ricordata dei vecchi western in cui il “cattivo” indossava vestiti neri e cavalcava un cavallo nero. Così, tanti messaggi subliminali hanno nutrito la distanza e la paura tra i bianchi e i neri. Ho deciso di non usare mai più quelle espressioni e ho cercato di essere fedele a questa scelta nel corso degli anni.
L’ultimo brusco risveglio è stato nel 2018. È iniziato alcuni anni prima, mentre insegnavo psicologia all’università. Era autunno. Io entrai nel dipartimento per il primo giorno di lezione e vidi, in un ufficio, una nuova professoressa, che supponevo fosse afroamericana. Mi sono precipitata nel suo ufficio, l’ho abbracciata e ho esclamato: “Finalmente una donna di colore nella nostra facoltà! Diventeremo grandi amiche!”. Ho scoperto molto più tardi che, nonostante il suo atteggiamento esteriore di cortese risposta al mio saluto, dentro di lei stava dicendo: “Questo non accadrà mai”. Un giorno le ho chiesto di venire a parlare, al mio corso di psicologia delle donne, dell’esperienza delle donne di colore. Lì ho anche scoperto che le sue origini erano giamaicane e non africane: ecco un’altra lezione su come non fare delle ipotesi senza fondamento. Siamo diventate veramente grandi amiche ed anche dopo il mio trasferimento in Italia, siamo riuscite a rimanere in contatto. Poco tempo fa abbiamo tenuto una relazione congiunta in una conferenza a Lublino, in Polonia, su come diventare persone di dialogo. È stato lì che ci siamo tanto divertite ricordando il nostro primo incontro. Mentre parlavamo, mi si è aperta una nuova comprensione: se la situazione fosse stata al contrario, lei non si sarebbe mai sentita libera di entrare nel mio ufficio e abbracciarmi. Lei stessa me lo ha confermato. In realtà, la mia libertà nel farlo era radicata nel “privilegio bianco”. Avevo agito con la certezza che lei mi avrebbe accolto e avrebbe apprezzato il mio gesto. Sono profondamente grata a questa straordinaria donna che mi ha aiutato a conoscere me stessa e a trovare un altro livello di pregiudizio che avevo bisogno di scoprire e affrontare.


Oggi, vivendo ancora in Italia, seguo le notizie dagli Stati Uniti con tristezza e paura. Avendo due pronipoti di razza mista, gli eventi hanno colpito da vicino la mia famiglia. Senz’altro sono invecchiata molto rispetto al 1965, ma la mia passione per la giustizia sociale è solo cresciuta con gli anni. Sono fermamente convinta che ciascuno di noi è chiamato ad essere agente di cambiamento in tutti i modi possibili. Ecco perché ho scritto questo articolo. Spero che queste mie parole possano fungere da catalizzatore e stimolare qualcuno a pensare in profondità e agire di conseguenza.
Nancy O’Donnell
Fonte: Loppiano.it
Foto in evidenza: Foto Freepik – www.freepik.es





