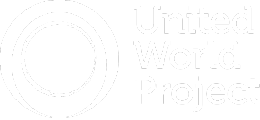Workshop
“I diritti umani sono la cura”. Intervista con Alessandra Morelli, ex delegata dell’UCHNR

Con oltre 30 anni di servizio nelle zone di conflitto per l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, Morelli analizza le attuali sfide in materia di diritti umani e come lavorare per ripristinare la dignità umana.
Alessandra Morelli è stata delegata dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR o UNHCR, le sigle in inglese) dal 1992 al 2021: quasi trent’anni di lavoro tra i paesi più fragili e sofferenti del mondo. Ha messo il cuore in questa lunga esperienza, anche rischiando la vita in un attentato a Mogadiscio, capitale della Somalia, sulla costa africana, nel 2014. Abbiamo dialogato con lei sul tema dei diritti umani partendo da una definizione che lei stessa ha dato di sé: “Donna di dialogo e mediazione cresciuta tra i colori e le culture del mondo”.

Alessandra, possiamo partire da questa definizione per raccontare la sua storia?
Sono stata concepita in India, appartengo a una famiglia che ha sempre viaggiato. Da qui la mia vita tra i colori, tra culture e paesi diversi. Fino al mio lavoro presso le Nazioni Unite: altro viaggio, stavolta tra paesi in conflitto. Donna di mediazione (umanistica, direi) e dialogo perché vissuta tra alterità mai sentite diverse da me. Non ho mai assolutizzato la mia identità. L’ho vissuta in comunione con gli altri. Questo non mi ha privato della mia unicità. Ha solo allargato il mio sguardo ribadendo che siamo parte della stessa umanità. Il conflitto nasce dall’assolutizzazione della propria identità. Sentirsi parte di altre culture conduce alla reciprocità.
Cosa significa operare nell’ACNUR?
Mi sono formata nelle emergenze. Mi sono immersa fino a sentire l’odore acre del conflitto, nelle guerre maggiori dopo il crollo del Muro di Berlino e delle Torri Gemelle. Anche in paesi dove si combatte il terrorismo. Amo definire il lavoro mio e dei miei colleghi come azione per aprire spazi: di dialogo, protezione, accoglienza e cura per chi è costretto a fuggire. Tra le frontiere internazionali e all’interno di uno stesso Paese. Spazio come ripresa della dignità, del soffio della vita. Ho sempre avuto a che fare con persone sradicate, prive di uno spazio che crei possibilità di futuro. La guerra cancella il luogo. Come ha detto Papa Francesco: “La guerra è il fallimento dell’essere umano”.
Cos’è il contrario della guerra?
L’accoglienza. Dà compimento alla salvaguardia della dignità umana, ma nella fortezza Europa è stata privata del suo significato profondo. È vista come la privazione di qualcosa. In tutte le religioni, soprattutto le tre monoteistiche, c’è il seme del divino nell’ospitalità. Anche la parola solidarietà è stata svuotata del suo senso profondo; quello, per dirlo con le parole di Stefano Rodotà (NdR: giurista e politico italiano), di bussola e risoluzione delle crisi umanitarie. Siamo scivolati nella tentazione del muro. Nel mio lavoro ho cercato di negoziare questi valori risolutivi con i governi dei paesi in cui ho operato. Per nutrire un’umanità offuscata dalla violenza.

Di recente, ha sviluppato un percorso tematico dal titolo Verso un’Economia della cura. Arte per restare umani. Che valore ha per i diritti umani?
Dopo 30 anni vissuti tra i diritti disattesi, in paesi dove il diritto internazionale non viene rispettato, ho cercato di dare forma narrativa alla mia esperienza. Nel mio primo libro, Mani che proteggono. Storie, luoghi, volti dei miei trent’anni fra guerre e conflitti, parlo di come si possa costantemente scivolare nel disumano.
Come vigilare su questo pericolo?
Mi sono chiesta quali fossero le parole per costruire, curare, da mettere urgentemente in circolazione. Accoglienza, ospitalità, ascolto, inclusione. La loro mancanza è un campanello di allarme in un contesto politico che parla di sostituzione etnica, di carico residuale, di esternalizzazione delle frontiere. Da qui il desiderio di riumanizzare attraverso meditazioni, conferenze e libri. Il primo libro e il secondo: Verso un’Economia della cura. Arte per restare umani. Umanizzare è un cammino di educazione. Erasmo da Rotterdam diceva: ´Umani si diventa´.
Come è cambiato il mondo in fatto di diritti umani? Evoluzione o involuzione?
La seconda. Dopo tanti anni tra i diritti umani negati, ho incontrato in Italia problematiche simili a quelle affrontate nel mio lavoro. La gestione delle migrazioni ci dice che non siamo consapevoli di essere parte della stessa comunità umana. Che non conosciamo la persona che fugge dai conflitti o per una vita migliore. Un confine liquido, com’è oggi quello tra richiedenti asilo e migranti economici: un corridoio purtroppo privo di vie legali. I paesi si chiudono sempre di più e con l’elezione di Trump ci allontaniamo dal concetto di reinsediamento. In Europa i diritti sono molto fragili, si gestiscono di pancia, assecondando gli umori popolari in funzione del voto. Per Platone la politica era la cura della comunità.

La solidarietà deve avere spazio nella politica?
L’ONU fu creata come strumento di speranza dopo la Seconda guerra mondiale: per dire “mai più” al riarmo sfrenato. Quel “mai più” passa anche per il multilateralismo. All’ONU nessun Paese si isola. Ragiona con gli altri su come risolvere il suo problema, ma oggi l’ONU è isolato, non gradito. Siamo tornati all’unilateralismo, come vediamo tra America e Russia. È il mondo neoliberale, dell’individualismo e del potere. Più si vive di potere, meno l’umano si esprime.
Quanto è importante parlare di diritti umani?
Non bisogna mollare la passione per i diritti umani: riportano al centro l’“homo reciprocans”, fermano la violenza. I diritti umani sono la cura. Custodiscono l’umano. Sono le sentinelle del benessere. Nella Bibbia la parola “sentinella” è spesso tradotta come “custode”.
Cosa può fare il semplice cittadino per i diritti umani?
Difenderli è compito di tutti e responsabilità del singolo. Come? Informandosi oltre le fake news e la propaganda. Cercando le fonti giuste con uno sguardo sconfinato sulla vastità del mondo, ben oltre il proprio orto. Educando. La cultura trasforma. La cultura fa crescere il rispetto per i diritti umani. Non tutti siamo chiamati a compiere grandi opere, ma tutti siamo chiamati a essere giardinieri.

Che potere ha l’ACNUR di portare la pace nel mondo?
Organizzazioni ONU come ACNUR, World Food Program, FAO, UNICEF, IFAD, rimangono dentro al conflitto fino a rischiare la vita dei suoi membri. È successo a me e a miei colleghi che hanno dato la vita per una causa di pace, di riconciliazione e dignità. Oggi l’ONU è a Gaza, in Ucraina… siamo quelli che raccolgono i cocci.
In che modo?
Siamo come i maestri vasai del ‘kintsukuroi’ (che è la copertina del mio secondo libro): coloro che trasfigurano i cocci rotti addirittura abbellendoli, seguendo con l’oro e l’argento le ferite, le crepe della rottura. Le agenzie ONU compiono gesti profetici tutti i giorni.
Come quello che compì lei stessa innalzando la bandiera dell’ACNUR sull’aeroporto di Mogadiscio, e le costò l’attentato che la ferì?
Molte persone mi dicevano: “A noi basta questo, perché sentiamo che non siamo soli”. È emozionante. Faccio un appello a sostenere queste organizzazioni e le ONG. Senza di loro sul territorio, tutto si oscurerebbe. Garantiscono il pane e la protezione che consente la vita e aiutano a conoscere la verità.

Quanto è importante la parola speranza sui diritti umani?
Fondamentale. L’ho imparata dagli occhi, dalle parole, dal comportamento di tanti rifugiati e sfollati che avevano perso tutto ma hanno sempre custodito la speranza. La speranza terrena è quella chiave che consente la sopravvivenza, ma si alimenta col lavoro di una comunità che cura. Poi c’è la speranza spirituale, della fede: che Dio ci lascia, ma ce la lascia, come diceva don Tonino Bello, per lavorarci sopra. La speranza è un dono che dobbiamo coltivare. Ecco perché ‘giardinieri’.
Quanto è importante formare i giovani, per migliorare sui diritti umani?
Educare è urgentissimo. Dalla consapevolezza nasce l’azione. Non si agisce se non dopo una profonda riflessione. Manca far comprendere ai nostri giovani che i diritti umani sono nel DNA degli esseri umani stessi. Sono la bussola, la mappa, sono parole di vita. Ma si può educare anche negli ambienti di lavoro. Occorre un cambio di paradigma. Uniamoci per attraversare con profezia questa fase buia, questo tempo di cuccagna del riarmo. Dopo trent’anni nelle guerre, dico che le armi non portano mai la pace.